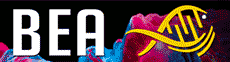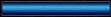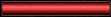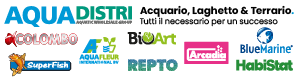Zolfo in mare e in acquario Marino - ciclo dello zolfo
-
Andrea Frigerio
- Chrysiptera
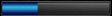
- Messaggi: 22
- Iscritto il: 18/06/2023, 20:43
Re: Zolfo in mare e in acquario Marino - ciclo dello zolfo
Gli ICP non sono miei, chiederò il permesso di pubblicarli. Grazie Davide e buon lavoro.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Re: Zolfo in mare e in acquario Marino - ciclo dello zolfo
Non esageriamo ora con la privacy, Sugli icp non ci sono nomi e/o dati personali ritenuti sensibili (non ci interessa di chi sono, è che devono essere della stessa vasca altrimenti non c'è un senso), anch'io ne ho a pc delle copie trovate in post e anche qui dal forum...
dal 30-04-2025 a mia tutela non intervengo più nelle conversazioni-.
shark tale & mafia method
Davide.
shark tale & mafia method
Davide.
-
Andrea Frigerio
- Chrysiptera
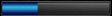
- Messaggi: 22
- Iscritto il: 18/06/2023, 20:43
Re: Zolfo in mare e in acquario Marino - ciclo dello zolfo
Ciao, ho estratto qualche passaggio che potrebbe interessarci dalla tesi di Cecchetti Nicoletta.
Per gli ICP chiedo in giro, magari potremmo raccoglierne qui sul forum per chi vuole contribuire a questo scopo.
Intanto mi focalizzo sulle reazioni aerobiche del batterio Thiobacillus
1.3
I microrganismi marini 1.3.1
La materia organica in ambiente marino La materia organica in ambiente marino costituisce una miscela complessa di composti organici con diversa composizione chimica, struttura fisica e reattività. Viene generalmente divisa in: POM (materiale organico particellato), composto da grandi macromolecole come i polimeri che concorrono alla struttura delle membrane e delle pareti, e DOM (materiale organico disciolto) composto da aminoacidi, carboidrati, acidi organici e acidi nucleici che sono assorbiti rapidamente dai microrganismi e riciclati.
La sostanza organica proviene di solito da batteri, fitoplancton e zooplancton nella colonna d'acqua. Il fitoplancton rappresenta la sorgente principale. La fissazione del carbonio inorganico in composti organici attraverso la fotosintesi, viene misurata come produzione primaria:
106 CO2 + 122 H2O + 16 HNO3 + H3PO4 → sostanza organica + 138 O2
Il carbonio inorganico e assimilato come bicarbonato (HCO3 - ), l’azoto come nitrato (NO3 - ), il fosforo come fosfato (PO4 3-) e lo zolfo come solfato (SO4 2-). L'entità della produzione primaria dipende da diversi fattori ambientali quali la temperatura e la torbidità dell'acqua, che influenza la luce trasmessa attraverso la colonna d'acqua, ma anche la disponibilità di nutrienti, primi tra tutti azoto e fosforo. Infatti la reazione evidenzia come il fitoplancton necessiti di questi nutrienti inorganici disciolti per portare a termine il processo fotosintetico.
Il DOM viene suddiviso in tre categorie in base alla disponibilità biologica: labile, semi- labile e recalcitrante. Il DOM labile può essere utilizzato dai microrganismi eterotrofi in pochi giorni o addirittura ore, il suo consumo rappresenta il principale flusso di energia, carbonio e nutrienti negli ecosistemi pelagici; quello semi-labile invece può persistere per mesi o anni in quanto resistente ad una rapida degradazione microbica. Il DOM recalcitrante essendo resistere alla decomposizione biologica, e il pool di carbonio piu persistente, può essere conservato per millenni nelle profondità marine.
In seguito allo sviluppo della microscopia ad epifluorescenza, e aumentato l’interesse verso la comunità microbica marina. Si scoprì che le cellule microbiche erano i veri regolatori dei flussi di energia e di nutrienti lungo la catena trofica. In Figura 8 possiamo osservare lo schema di un ecosistema marino strutturato dalla componente microbica. Il DOC labile viene rapidamente utilizzato dai batteri eterotrofi che lo convertono in nuova biomassa. L’utilizzo della materia organica rilasciata dal fitoplancton o da altre fonti da parte dei batteri, e una via nella rete trofica marina indicata come “microbial loop”. In questo loop il batterioplancton mineralizza a CO2 una parte del carbonio organico e assimila il rimanente per produrre biomassa. Reazioni fotochimiche sono stimolati dalla luce,
I batteri sono responsabili della degradazione e del riciclo di elementi essenziali come carbonio, azoto e fosforo, possono inoltre influenzare la disponibilità di metalli pesanti e svolgere altri importanti servizi ecosistemici. In particolare, processi quali l'azotofissazione, la respirazione anaerobica, la nitrificazione, sono mediati esclusivamente dai microrganismi. La maggiore diversità microbica si ritrova nei sedimenti, dove la materia organica, che deriva principalmente da organismi morti, si deposita
i numeri di cellule batteriche e i tassi di produzione e di crescita, sono di solito correlati
con i flussi di materiale organico disciolto e particolato
1.4 Il metabolismo dei microrganismi nella decomposizione della materia organica può
essere aerobico se viene consumato ossigeno o anaerobico se vengono utilizzati altri componenti per ossidare la materia organica, detti ossidanti secondari (NO3 - , MnO2, Fe2O3 e SO4 2-). L’ossigeno, quando presente, e l'accettore di elettroni preferito. Quando l’ossigeno viene consumato, i batteri utilizzano gli altri accettori, secondo una sequenza denominata da Froelich et al. (1979) “sequenza diagenetica” (Figura 9). Le reazioni redox favorite dal punto di vista energetico avvengono prima e gli accettori di elettroni non si sovrappongono tra di loro in maniera significativa. Assumendo che la composizione della sostanza organica soggetta a degradazione sia simile a quella delle cellule fitoplanctoniche, ovvero che il rapporto C:N:P rispetti il rapporto di Redfield Richards (106:16:1), la sequenza diagenetica ideale e quindi la seguente: nitrati, ossidi di Mn, ossidi di Fe e solfati. I processi di denitrificazione precedono quelli di riduzione degli ossidi di Mn e Fe, la solfato-riduzione e la metanogenesi. In presenza di ossigeno la reazione di ossidazione della sostanza organica e la seguente:
(CH2O)106 (NH3)16 (H3PO4) + 138 O2 16 NH3 + 106 CO2 + H3PO4 + 122 H2O
In assenza di ossigeno, il nitrato (NO3 - ) entra in gioco nei processi di decomposizione anaerobica della materia organica secondo la reazione:
5 (CH2O)106 (NH3)16 (H3PO4) + 472 HNO3 76 N2 + 520 CO2 + 5 H3PO4 + 886 H2O
Questo processo e detto di denitrificazione.
Quando viene utilizzato manganese (MnO2) la reazione e la seguente:
(CH2O)106 (NH3)16 (H3PO4) + 236 MnO2 + 472 H+ 236 Mn2++ 106 CO2 + 8 N2 + H3PO4 + 336 H2O
Segue l'ossidazione del ferro (Fe2O3) secondo la seguente reazione:
(CH2O)106 (NH3)16 (H3PO4) + 212 Fe2O3 + 848 H+ 434 Fe2+ + 106 CO2 + 16 NH3 + H3PO4 + 530 H2O
1.3.4 Ciclo dello zolfo
Lo zolfo e il decimo elemento per abbondanza nella crosta terrestre ed e il sesto per abbondanza negli oceani con una concentrazione di 928 ppm. È anche uno dei costituenti essenziali per i processi biosintetici di tutti gli organismi viventi. Nella crosta terrestre si presenta nella forma di minerali contenenti solfati (esempio il gesso CaSO4) e di minerali contenenti solfuri (esempio la pirite FeS2), quindi in forme poco disponibili alle trasformazioni biologiche. Nell'acqua di mare si trova principalmente nella forma di ione solfato (SO4 2-), il piu accessibile per gli organismi viventi, ma si può trovare anche come solfuro di idrogeno (H2S), zolfo elementare (S0 ) e molecole organiche solforate. Gli oceani rappresentano per questo il piu importante serbatoio di zolfo. Nelle cellule viventi lo zolfo e parte della struttura di molte molecole come amminoacidi (esempio metionina, cisteina), alcune vitamine, coenzimi e ormoni. Lo zolfo e anche utilizzato da diversi gruppi batterici, soprattutto nelle sue forme inorganiche, nei processi di produzione di energia metabolica.
Il ciclo biogeochimico dello zolfo (Figura 10) comprende varie specie, organiche e inorganiche, che subiscono trasformazioni ad opera di agenti chimici o biologici, e che fluiscono tra i diversi comparti naturali.
Lo zolfo elementare viene ossidato aerobicamente da batteri zolfo ossidanti producendo ancora solfato. Il solfato viene assimilato da una serie di microrganismi e organismi vegetali dando di nuovo via al ciclo.
Il riciclo dello S nella biosfera e molto rapido e i microrganismi marini hanno un ruolo fondamentale. Come risultato di queste attività microbiche, il ciclo dello S ha connessioni multiple con i cicli degli altri elementi, in particolare C, N, P e Fe.
1.3.5 Il DMS e l'influenza sul clima
Come già detto nel paragrafo precedente, lo zolfo nella zona fotica viene assimilato dal
fitoplancton e incorporato, in forma ossidata, in polisaccaridi solforati, ma soprattutto in aminoacidi quali metionina e cisteina. La metionina e convertita dal fitoplancton in dimetilsolfoniopropionato (CH3)2S +CH2CH2COO- (DMSP) un composto con diverse funzioni. Il suo effetto principale e osmoprotettivo in molte alghe, batteri e alcune piante acquatiche, in cui regola gli scambi osmotici tra l'ambiente esterno ed l'interno della cellula. Ma ha anche altre funzioni: citoprotettivo, chemioprotettivo, ha un’attività antiossidante in alcune alghe marine e può limitare la predazione da parte dello zooplancton. Questo composto può raggiungere concentrazioni citoplasmatiche anche molto elevate; complessivamente il DMSP sintetizzato annualmente dai fotoautotrofi marini ammonta a circa 109 tonnellate. Poiché ogni molecola di DMSP contiene 5 atomi di C, la sintesi di questo composto e importante anche per il ciclo del carbonio. Il 3-10% del carbonio fissato nella produzione primaria va a formare questa molecola, e quindi la sua degradazione fornisce circa il 3-10% della domanda di carbonio dei batteri eterotrofi nella zona oceanica superficiale. Il DMSP viene successivamente rilasciato dal fitoplancton nell'ambiente esterno, in parte con la cosidetta essudazione, ma soprattutto a seguito di lisi cellulare, predazione, morte, e diventa così un elemento appetibile per molti organismi presenti in loco, tra cui batteri eterotrofi che lo utilizzano come fonte di carbonio, di energia, ma anche di zolfo, già presente in forma organica utilizzabile quindi per la biosintesi degli aminoacidi. Il DMSP può subire due vie degradative diverse: 1. demetilazione con formazione di MMPA (3metil-mercaptiopropionato) che poi porta alla formazione di metanotiolo, il quale viene in seguito inserito nella via di sintesi degli aminoacidi; 2. rottura del DMSP con formazione di DMS, e la parte preponderante, circa il 90%, viene degradata da microrganismi anaerobi e aerobi
Generalmente solo circa il 10% del solfuro prodotto dai solfato riduttori viene precipitato da ioni metallici. Il resto e potenzialmente disponibile per l'ossidazione a S0 da parte di batteri chemiolitotrofi in grado di ossidare solfuro, zolfo elementare o tiosolfato (S2O3 2-) formando solfato come prodotto finale, stimolando nuovamente l'attività dei batteri solfato-riduttori. Si tratta di microrganismi microerofili in quanto crescono preferibilmente in presenza di basse concentrazioni di ossigeno. In questo processo di ossidazione molto importanti risultano essere i batteri filamentosi Beggiatoa e Thiothrix, Thiomargarita. Si tratta di tre generi, strettamente correlati, che si sono adattati a ossidare il solfuro anche in assenza di O2 utilizzando il nitrato come accettore di elettroni. Per riuscire a competere con altri solfuro-ossidanti, essi immagazzinano il nitrato delle acque profonde in un vacuolo e lo trasportano nel sedimento dove e prodotto il solfuro. Per incamerare piu nitrato possibile, essi devono ingrandire i loro vacuoli e, come risultato, questo gruppo comprende diverse specie giganti visibili anche
a occhio nudo. Questi grandi solfo-batteri utilizzano nitrato ma, contrariamente ai batteri denitrificanti, sembra che riducano il nitrato ad ammoniaca e non a N2. Quando la zona anaerobica coinvolge anche una porzione di colonna d'acqua dove penetra la luce, si possono sviluppare batteri fototrofi che utilizzano composti ridotti dello zolfo non a scopo energetico, ma come sorgente di elettroni per la fissazione della CO2 nel processo della fotosintesi anossigenica. Questi microrganismi sono raggruppati come solfobatteri purpurei (ad esempio Chromatium, Thiocapsa, Thiopedia spp.) o verdi (ad esempio Chlorobium, Pelodictyon, Prosthecochlarius),
1- determinare la presenza o l'assenza di batteri solfato-riduttori nei campioni di acqua e sedimento, con utilizzo di una metodologia molecolare basata sull’estrazione dell’eDNA (environmental DNA) dalle matrici ambientali e la successiva amplificazione (PCR) di un tratto genico codificante l’enzima dissimilatory sulfite reductase (solfito reduttasi) (dsrAB), specifico dei procarioti solfato-riduttori;
Per l’analisi della concentrazione dei solfuri e stato utilizzato il metodo del blu di metilene (USEPA 376.2, Sulfide reagents, Hach Lange) sul campione d’acqua tal quale (25 mL).
Dopo l’analisi dei solfuri, i campioni d’acqua sono stati divisi in due aliquote 250 mL e filtrati con filtri in fibra di vetro (porosità 0.4 μm, Whatman GF6). L'acqua filtrata e stata utilizzata per determinare le concentrazioni di solfati, nitrati e fosfati, usando i seguenti metodi:
Tabella 2. Metodi utilizzati per determinare le concentrazioni di solfati, nitrati e fosfati nei campioni di acqua.
ELEMENTO Solfati Nitrati Fosfati
METODO
USEPA 375.4 (SulfaVer 4 kit, Hach Lange)
riduzione del Cd (Nitraver 5 kit, Hach Lange) acido ascorbico, USEPA 365.2 (PhosVer 3 kit, Hach Lange)
La concentrazione di ossigeno disciolto in un ambiente acquatico e un importante indicatore della qualità dell’acqua. I principali fattori influenzanti la quantità di ossigeno disciolto sono: salinità, temperatura, attività fotosintetica, percentuale di ossigeno atmosferico e presenza di sostanze organiche biodegradabili. A causa dell’attività dei vegetali, il livello di ossigeno disciolto può fluttuare durante il giorno, crescendo durante le ore mattutine e raggiungendo un picco nel pomeriggio. Di notte la fotosintesi cessa, ma tutti gli organismi continuano a respirare, causando un decremento del livello di ossigeno disciolto. La temperatura e un fattore chiave per ciò che riguarda la capacità dell’ossigeno di sciogliersi in acqua, poiché l’ossigeno, come tutti i gas, possiede valori differenti di solubilità al variare della temperatura. L’ossigeno si scioglie piu facilmente in acqua fredda piuttosto che in quella calda.
Nel nostro studio si possono osservare delle lievi oscillazioni di questo parametro che però risulta mantenersi a valori medi di circa 8 ppm.
In tutti i campioni di acqua prelevati dai siti analizzati per gli scopi di questa Tesi non sono stati rilevati livelli misurabili di solfuri, mentre le concentrazioni di solfato oscillano intorno al valore di 2.700 mg/l, concentrazioni tipiche dell'acqua di mare. Questo elemento non risulta essere limitante per i batteri solfato-riduttori che possono quindi svilupparsi in queste acque
Queste osservazioni sono state anche confermate dalle analisi molecolari (Figura 20) che hanno permesso di identificare i siti interessati dalla presenza di batteri solfatoriduttori. Le analisi sono state condotte applicando le moderne tecnologie biomolecolari che prevedono l’amplificazione selettiva tramite PCR di tratti genici esclusivi del genoma batterico partendo dal DNA estratto dalle diverse matrici ambientali.
In particolare, la presenza di DNA dei solfato-riduttori e stata rilevata mediante l’amplificazione del gene codificante l’enzima solfito reduttasi (DsrAB); questo enzima svolge un ruolo chiave nel processo biochimico riduzione dei solfati,
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Per gli ICP chiedo in giro, magari potremmo raccoglierne qui sul forum per chi vuole contribuire a questo scopo.
Intanto mi focalizzo sulle reazioni aerobiche del batterio Thiobacillus
1.3
I microrganismi marini 1.3.1
La materia organica in ambiente marino La materia organica in ambiente marino costituisce una miscela complessa di composti organici con diversa composizione chimica, struttura fisica e reattività. Viene generalmente divisa in: POM (materiale organico particellato), composto da grandi macromolecole come i polimeri che concorrono alla struttura delle membrane e delle pareti, e DOM (materiale organico disciolto) composto da aminoacidi, carboidrati, acidi organici e acidi nucleici che sono assorbiti rapidamente dai microrganismi e riciclati.
La sostanza organica proviene di solito da batteri, fitoplancton e zooplancton nella colonna d'acqua. Il fitoplancton rappresenta la sorgente principale. La fissazione del carbonio inorganico in composti organici attraverso la fotosintesi, viene misurata come produzione primaria:
106 CO2 + 122 H2O + 16 HNO3 + H3PO4 → sostanza organica + 138 O2
Il carbonio inorganico e assimilato come bicarbonato (HCO3 - ), l’azoto come nitrato (NO3 - ), il fosforo come fosfato (PO4 3-) e lo zolfo come solfato (SO4 2-). L'entità della produzione primaria dipende da diversi fattori ambientali quali la temperatura e la torbidità dell'acqua, che influenza la luce trasmessa attraverso la colonna d'acqua, ma anche la disponibilità di nutrienti, primi tra tutti azoto e fosforo. Infatti la reazione evidenzia come il fitoplancton necessiti di questi nutrienti inorganici disciolti per portare a termine il processo fotosintetico.
Il DOM viene suddiviso in tre categorie in base alla disponibilità biologica: labile, semi- labile e recalcitrante. Il DOM labile può essere utilizzato dai microrganismi eterotrofi in pochi giorni o addirittura ore, il suo consumo rappresenta il principale flusso di energia, carbonio e nutrienti negli ecosistemi pelagici; quello semi-labile invece può persistere per mesi o anni in quanto resistente ad una rapida degradazione microbica. Il DOM recalcitrante essendo resistere alla decomposizione biologica, e il pool di carbonio piu persistente, può essere conservato per millenni nelle profondità marine.
In seguito allo sviluppo della microscopia ad epifluorescenza, e aumentato l’interesse verso la comunità microbica marina. Si scoprì che le cellule microbiche erano i veri regolatori dei flussi di energia e di nutrienti lungo la catena trofica. In Figura 8 possiamo osservare lo schema di un ecosistema marino strutturato dalla componente microbica. Il DOC labile viene rapidamente utilizzato dai batteri eterotrofi che lo convertono in nuova biomassa. L’utilizzo della materia organica rilasciata dal fitoplancton o da altre fonti da parte dei batteri, e una via nella rete trofica marina indicata come “microbial loop”. In questo loop il batterioplancton mineralizza a CO2 una parte del carbonio organico e assimila il rimanente per produrre biomassa. Reazioni fotochimiche sono stimolati dalla luce,
I batteri sono responsabili della degradazione e del riciclo di elementi essenziali come carbonio, azoto e fosforo, possono inoltre influenzare la disponibilità di metalli pesanti e svolgere altri importanti servizi ecosistemici. In particolare, processi quali l'azotofissazione, la respirazione anaerobica, la nitrificazione, sono mediati esclusivamente dai microrganismi. La maggiore diversità microbica si ritrova nei sedimenti, dove la materia organica, che deriva principalmente da organismi morti, si deposita
i numeri di cellule batteriche e i tassi di produzione e di crescita, sono di solito correlati
con i flussi di materiale organico disciolto e particolato
1.4 Il metabolismo dei microrganismi nella decomposizione della materia organica può
essere aerobico se viene consumato ossigeno o anaerobico se vengono utilizzati altri componenti per ossidare la materia organica, detti ossidanti secondari (NO3 - , MnO2, Fe2O3 e SO4 2-). L’ossigeno, quando presente, e l'accettore di elettroni preferito. Quando l’ossigeno viene consumato, i batteri utilizzano gli altri accettori, secondo una sequenza denominata da Froelich et al. (1979) “sequenza diagenetica” (Figura 9). Le reazioni redox favorite dal punto di vista energetico avvengono prima e gli accettori di elettroni non si sovrappongono tra di loro in maniera significativa. Assumendo che la composizione della sostanza organica soggetta a degradazione sia simile a quella delle cellule fitoplanctoniche, ovvero che il rapporto C:N:P rispetti il rapporto di Redfield Richards (106:16:1), la sequenza diagenetica ideale e quindi la seguente: nitrati, ossidi di Mn, ossidi di Fe e solfati. I processi di denitrificazione precedono quelli di riduzione degli ossidi di Mn e Fe, la solfato-riduzione e la metanogenesi. In presenza di ossigeno la reazione di ossidazione della sostanza organica e la seguente:
(CH2O)106 (NH3)16 (H3PO4) + 138 O2 16 NH3 + 106 CO2 + H3PO4 + 122 H2O
In assenza di ossigeno, il nitrato (NO3 - ) entra in gioco nei processi di decomposizione anaerobica della materia organica secondo la reazione:
5 (CH2O)106 (NH3)16 (H3PO4) + 472 HNO3 76 N2 + 520 CO2 + 5 H3PO4 + 886 H2O
Questo processo e detto di denitrificazione.
Quando viene utilizzato manganese (MnO2) la reazione e la seguente:
(CH2O)106 (NH3)16 (H3PO4) + 236 MnO2 + 472 H+ 236 Mn2++ 106 CO2 + 8 N2 + H3PO4 + 336 H2O
Segue l'ossidazione del ferro (Fe2O3) secondo la seguente reazione:
(CH2O)106 (NH3)16 (H3PO4) + 212 Fe2O3 + 848 H+ 434 Fe2+ + 106 CO2 + 16 NH3 + H3PO4 + 530 H2O
1.3.4 Ciclo dello zolfo
Lo zolfo e il decimo elemento per abbondanza nella crosta terrestre ed e il sesto per abbondanza negli oceani con una concentrazione di 928 ppm. È anche uno dei costituenti essenziali per i processi biosintetici di tutti gli organismi viventi. Nella crosta terrestre si presenta nella forma di minerali contenenti solfati (esempio il gesso CaSO4) e di minerali contenenti solfuri (esempio la pirite FeS2), quindi in forme poco disponibili alle trasformazioni biologiche. Nell'acqua di mare si trova principalmente nella forma di ione solfato (SO4 2-), il piu accessibile per gli organismi viventi, ma si può trovare anche come solfuro di idrogeno (H2S), zolfo elementare (S0 ) e molecole organiche solforate. Gli oceani rappresentano per questo il piu importante serbatoio di zolfo. Nelle cellule viventi lo zolfo e parte della struttura di molte molecole come amminoacidi (esempio metionina, cisteina), alcune vitamine, coenzimi e ormoni. Lo zolfo e anche utilizzato da diversi gruppi batterici, soprattutto nelle sue forme inorganiche, nei processi di produzione di energia metabolica.
Il ciclo biogeochimico dello zolfo (Figura 10) comprende varie specie, organiche e inorganiche, che subiscono trasformazioni ad opera di agenti chimici o biologici, e che fluiscono tra i diversi comparti naturali.
Lo zolfo elementare viene ossidato aerobicamente da batteri zolfo ossidanti producendo ancora solfato. Il solfato viene assimilato da una serie di microrganismi e organismi vegetali dando di nuovo via al ciclo.
Il riciclo dello S nella biosfera e molto rapido e i microrganismi marini hanno un ruolo fondamentale. Come risultato di queste attività microbiche, il ciclo dello S ha connessioni multiple con i cicli degli altri elementi, in particolare C, N, P e Fe.
1.3.5 Il DMS e l'influenza sul clima
Come già detto nel paragrafo precedente, lo zolfo nella zona fotica viene assimilato dal
fitoplancton e incorporato, in forma ossidata, in polisaccaridi solforati, ma soprattutto in aminoacidi quali metionina e cisteina. La metionina e convertita dal fitoplancton in dimetilsolfoniopropionato (CH3)2S +CH2CH2COO- (DMSP) un composto con diverse funzioni. Il suo effetto principale e osmoprotettivo in molte alghe, batteri e alcune piante acquatiche, in cui regola gli scambi osmotici tra l'ambiente esterno ed l'interno della cellula. Ma ha anche altre funzioni: citoprotettivo, chemioprotettivo, ha un’attività antiossidante in alcune alghe marine e può limitare la predazione da parte dello zooplancton. Questo composto può raggiungere concentrazioni citoplasmatiche anche molto elevate; complessivamente il DMSP sintetizzato annualmente dai fotoautotrofi marini ammonta a circa 109 tonnellate. Poiché ogni molecola di DMSP contiene 5 atomi di C, la sintesi di questo composto e importante anche per il ciclo del carbonio. Il 3-10% del carbonio fissato nella produzione primaria va a formare questa molecola, e quindi la sua degradazione fornisce circa il 3-10% della domanda di carbonio dei batteri eterotrofi nella zona oceanica superficiale. Il DMSP viene successivamente rilasciato dal fitoplancton nell'ambiente esterno, in parte con la cosidetta essudazione, ma soprattutto a seguito di lisi cellulare, predazione, morte, e diventa così un elemento appetibile per molti organismi presenti in loco, tra cui batteri eterotrofi che lo utilizzano come fonte di carbonio, di energia, ma anche di zolfo, già presente in forma organica utilizzabile quindi per la biosintesi degli aminoacidi. Il DMSP può subire due vie degradative diverse: 1. demetilazione con formazione di MMPA (3metil-mercaptiopropionato) che poi porta alla formazione di metanotiolo, il quale viene in seguito inserito nella via di sintesi degli aminoacidi; 2. rottura del DMSP con formazione di DMS, e la parte preponderante, circa il 90%, viene degradata da microrganismi anaerobi e aerobi
Generalmente solo circa il 10% del solfuro prodotto dai solfato riduttori viene precipitato da ioni metallici. Il resto e potenzialmente disponibile per l'ossidazione a S0 da parte di batteri chemiolitotrofi in grado di ossidare solfuro, zolfo elementare o tiosolfato (S2O3 2-) formando solfato come prodotto finale, stimolando nuovamente l'attività dei batteri solfato-riduttori. Si tratta di microrganismi microerofili in quanto crescono preferibilmente in presenza di basse concentrazioni di ossigeno. In questo processo di ossidazione molto importanti risultano essere i batteri filamentosi Beggiatoa e Thiothrix, Thiomargarita. Si tratta di tre generi, strettamente correlati, che si sono adattati a ossidare il solfuro anche in assenza di O2 utilizzando il nitrato come accettore di elettroni. Per riuscire a competere con altri solfuro-ossidanti, essi immagazzinano il nitrato delle acque profonde in un vacuolo e lo trasportano nel sedimento dove e prodotto il solfuro. Per incamerare piu nitrato possibile, essi devono ingrandire i loro vacuoli e, come risultato, questo gruppo comprende diverse specie giganti visibili anche
a occhio nudo. Questi grandi solfo-batteri utilizzano nitrato ma, contrariamente ai batteri denitrificanti, sembra che riducano il nitrato ad ammoniaca e non a N2. Quando la zona anaerobica coinvolge anche una porzione di colonna d'acqua dove penetra la luce, si possono sviluppare batteri fototrofi che utilizzano composti ridotti dello zolfo non a scopo energetico, ma come sorgente di elettroni per la fissazione della CO2 nel processo della fotosintesi anossigenica. Questi microrganismi sono raggruppati come solfobatteri purpurei (ad esempio Chromatium, Thiocapsa, Thiopedia spp.) o verdi (ad esempio Chlorobium, Pelodictyon, Prosthecochlarius),
1- determinare la presenza o l'assenza di batteri solfato-riduttori nei campioni di acqua e sedimento, con utilizzo di una metodologia molecolare basata sull’estrazione dell’eDNA (environmental DNA) dalle matrici ambientali e la successiva amplificazione (PCR) di un tratto genico codificante l’enzima dissimilatory sulfite reductase (solfito reduttasi) (dsrAB), specifico dei procarioti solfato-riduttori;
Per l’analisi della concentrazione dei solfuri e stato utilizzato il metodo del blu di metilene (USEPA 376.2, Sulfide reagents, Hach Lange) sul campione d’acqua tal quale (25 mL).
Dopo l’analisi dei solfuri, i campioni d’acqua sono stati divisi in due aliquote 250 mL e filtrati con filtri in fibra di vetro (porosità 0.4 μm, Whatman GF6). L'acqua filtrata e stata utilizzata per determinare le concentrazioni di solfati, nitrati e fosfati, usando i seguenti metodi:
Tabella 2. Metodi utilizzati per determinare le concentrazioni di solfati, nitrati e fosfati nei campioni di acqua.
ELEMENTO Solfati Nitrati Fosfati
METODO
USEPA 375.4 (SulfaVer 4 kit, Hach Lange)
riduzione del Cd (Nitraver 5 kit, Hach Lange) acido ascorbico, USEPA 365.2 (PhosVer 3 kit, Hach Lange)
La concentrazione di ossigeno disciolto in un ambiente acquatico e un importante indicatore della qualità dell’acqua. I principali fattori influenzanti la quantità di ossigeno disciolto sono: salinità, temperatura, attività fotosintetica, percentuale di ossigeno atmosferico e presenza di sostanze organiche biodegradabili. A causa dell’attività dei vegetali, il livello di ossigeno disciolto può fluttuare durante il giorno, crescendo durante le ore mattutine e raggiungendo un picco nel pomeriggio. Di notte la fotosintesi cessa, ma tutti gli organismi continuano a respirare, causando un decremento del livello di ossigeno disciolto. La temperatura e un fattore chiave per ciò che riguarda la capacità dell’ossigeno di sciogliersi in acqua, poiché l’ossigeno, come tutti i gas, possiede valori differenti di solubilità al variare della temperatura. L’ossigeno si scioglie piu facilmente in acqua fredda piuttosto che in quella calda.
Nel nostro studio si possono osservare delle lievi oscillazioni di questo parametro che però risulta mantenersi a valori medi di circa 8 ppm.
In tutti i campioni di acqua prelevati dai siti analizzati per gli scopi di questa Tesi non sono stati rilevati livelli misurabili di solfuri, mentre le concentrazioni di solfato oscillano intorno al valore di 2.700 mg/l, concentrazioni tipiche dell'acqua di mare. Questo elemento non risulta essere limitante per i batteri solfato-riduttori che possono quindi svilupparsi in queste acque
Queste osservazioni sono state anche confermate dalle analisi molecolari (Figura 20) che hanno permesso di identificare i siti interessati dalla presenza di batteri solfatoriduttori. Le analisi sono state condotte applicando le moderne tecnologie biomolecolari che prevedono l’amplificazione selettiva tramite PCR di tratti genici esclusivi del genoma batterico partendo dal DNA estratto dalle diverse matrici ambientali.
In particolare, la presenza di DNA dei solfato-riduttori e stata rilevata mediante l’amplificazione del gene codificante l’enzima solfito reduttasi (DsrAB); questo enzima svolge un ruolo chiave nel processo biochimico riduzione dei solfati,
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Re: Zolfo in mare e in acquario Marino - ciclo dello zolfo
Ciao,
perdonami ma sono saltato alle "VALUTAZIONI FINALI", dove nel primo capo si evidenzia la sintesi della tesi stessa:
Quindi una "possibile" variazione del S in ICP potrebbe "solo" confermare la presenza di zone anossiche con sviluppo di batteri NO3 riducenti (se in DSB o roccia viva/sintetica, non lo sapremo mai) cosa positiva se non fosse per l'anossia...
Davide
perdonami ma sono saltato alle "VALUTAZIONI FINALI", dove nel primo capo si evidenzia la sintesi della tesi stessa:
Che i batteri nitrificanti utilizzino S è risaputo, visto anche quanto ho riportato sopra (testi compresi)."Il presente studio ha dimostrato la presenza dei batteri solfato-riduttori nella laguna costiera Pialassa dei Piomboni nei mesi di Novembre-Dicembre. Come già anticipato nel capitolo 2, si tratta di batteri che normalmente si sviluppano in estate, periodo dell'anno in cui si verificano aumenti della temperatura, ristagni dell'acqua e conseguenti fenomeni anossici nei fondali. Il fatto di ritrovare questi batteri in inverno, fa supporre che la zona sia fortemente soggetta a stratificazioni occasionali. I motivi di ciò non sono stati dimostrati ma sono probabilmente legati ad un insieme di fattori..."
Quindi una "possibile" variazione del S in ICP potrebbe "solo" confermare la presenza di zone anossiche con sviluppo di batteri NO3 riducenti (se in DSB o roccia viva/sintetica, non lo sapremo mai) cosa positiva se non fosse per l'anossia...
Davide
dal 30-04-2025 a mia tutela non intervengo più nelle conversazioni-.
shark tale & mafia method
Davide.
shark tale & mafia method
Davide.
-
Andrea Frigerio
- Chrysiptera
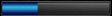
- Messaggi: 22
- Iscritto il: 18/06/2023, 20:43
Re: Zolfo in mare e in acquario Marino - ciclo dello zolfo
Lo zolfo elementare viene ossidato aerobicamente da batteri zolfo ossidanti producendo ancora solfato. Il solfato viene assimilato da una serie di microrganismi e organismi vegetali dando di nuovo via al ciclo.
Come già detto nel paragrafo precedente, lo zolfo nella zona fotica viene assimilato dal
fitoplancton e incorporato, in forma ossidata, in polisaccaridi solforati, ma soprattutto in aminoacidi quali metionina e cisteina.
Se intendo bene il testo, lo zolfo viene anche assimilato dal fitoplancton
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Come già detto nel paragrafo precedente, lo zolfo nella zona fotica viene assimilato dal
fitoplancton e incorporato, in forma ossidata, in polisaccaridi solforati, ma soprattutto in aminoacidi quali metionina e cisteina.
Se intendo bene il testo, lo zolfo viene anche assimilato dal fitoplancton
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
-
Andrea Frigerio
- Chrysiptera
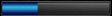
- Messaggi: 22
- Iscritto il: 18/06/2023, 20:43
Re: Zolfo in mare e in acquario Marino - ciclo dello zolfo
Provo a stringere il più possibile i passaggi che potrebbero interessare così:
I batteri sono responsabili della degradazione e del riciclo di elementi essenziali come carbonio, azoto e fosforo, possono inoltre influenzare la disponibilità di metalli pesanti e svolgere altri importanti servizi ecosistemici.
Lo zolfo e il decimo elemento per abbondanza nella crosta terrestre ed e il sesto per abbondanza negli oceani con una concentrazione di 928 ppm.
È anche uno dei costituenti essenziali per i processi biosintetici di tutti gli organismi viventi.
Nell'acqua di mare si trova principalmente nella forma di ione solfato (SO4 2-), il piu accessibile per gli organismi viventi, ma si può trovare anche come solfuro di idrogeno (H2S), zolfo elementare (S0 ) e molecole organiche solforate.
Lo zolfo e anche utilizzato da diversi gruppi batterici, soprattutto nelle sue forme inorganiche, nei processi di produzione di energia metabolica.
Nelle cellule viventi lo zolfo è parte della struttura di molte molecole come amminoacidi (esempio metionina, cisteina), alcune vitamine, coenzimi e ormoni. Lo zolfo è anche utilizzato da diversi gruppi batterici, soprattutto nelle sue forme inorganiche, nei processi di produzione di energia metabolica.
Il ciclo biogeochimico dello zolfo comprende varie specie, organiche e inorganiche, che subiscono trasformazioni ad opera di agenti chimici o biologici, e che fluiscono tra i diversi comparti naturali.
Lo zolfo elementare viene ossidato aerobicamente da batteri zolfo ossidanti producendo ancora solfato.
Il solfato viene assimilato da una serie di microrganismi e organismi vegetali dando di nuovo via al ciclo.
Il riciclo dello S nella biosfera e molto rapido e i microrganismi marini hanno un ruolo fondamentale.
Come risultato di queste attività microbiche, il ciclo dello S ha connessioni multiple con i cicli degli altri elementi, in particolare C, N, P e Fe.
lo zolfo nella zona fotica viene assimilato dal fitoplancton e incorporato, in forma ossidata, in polisaccaridi solforati, ma soprattutto in aminoacidi quali metionina e cisteina.
La metionina e convertita dal fitoplancton in dimetilsolfoniopropionato (CH3)2S +CH2CH2COO- (DMSP) un composto con diverse funzioni.
Il suo effetto principale e osmoprotettivo in molte alghe, batteri e alcune piante acquatiche, in cui regola gli scambi osmotici tra l'ambiente esterno ed l'interno della cellula.
Ma ha anche altre funzioni: citoprotettivo, chemioprotettivo, ha un’attività antiossidante in alcune alghe marine e può limitare la predazione da parte dello zooplancton.
Poiché ogni molecola di DMSP contiene 5 atomi di C, la sintesi di questo composto e importante anche per il ciclo del carbonio.
Il 3-10% del carbonio fissato nella produzione primaria va a formare questa molecola, e quindi la sua degradazione fornisce circa il 3-10% della domanda di carbonio dei batteri eterotrofi nella zona oceanica superficiale.
Il DMSP viene successivamente rilasciato dal fitoplancton nell'ambiente esterno, in parte con la cosidetta essudazione, ma soprattutto a seguito di lisi cellulare, predazione, morte, e diventa così un elemento appetibile per molti organismi presenti in loco, tra cui batteri eterotrofi che lo utilizzano come fonte di carbonio, di energia, ma anche di zolfo, già presente in forma organica utilizzabile quindi per la biosintesi degli aminoacidi.
Il DMSP può subire due vie degradative diverse: 1. demetilazione con formazione di MMPA (3metil-mercaptiopropionato) che poi porta alla formazione di metanotiolo, il quale viene in seguito inserito nella via di sintesi degli aminoacidi;
2. rottura del DMSP con formazione di DMS, e la parte preponderante, circa il 90%, viene degradata da microrganismi anaerobi e aerobi.
Generalmente solo circa il 10% del solfuro prodotto dai solfato riduttori viene precipitato da ioni metallici.
Il resto è potenzialmente disponibile per l'ossidazione a S0 da parte di batteri chemiolitotrofi in grado di ossidare solfuro, zolfo elementare o tiosolfato (S2O3 2-) formando solfato come prodotto finale, stimolando nuovamente l'attività dei batteri solfato-riduttori.
Si tratta di microrganismi microerofili in quanto crescono preferibilmente in presenza di basse concentrazioni di ossigeno.
In questo processo di ossidazione molto importanti risultano essere i batteri filamentosi Beggiatoa e Thiothrix, Thiomargarita.
Si tratta di tre generi, strettamente correlati, che si sono adattati a ossidare il solfuro anche in assenza di O2 utilizzando il nitrato come accettore di elettroni.
Per riuscire a competere con altri solfuro-ossidanti, essi immagazzinano il nitrato delle acque profonde in un vacuolo e lo trasportano nel sedimento dove e prodotto il solfuro.
Per incamerare piu nitrato possibile, essi devono ingrandire i loro vacuoli e, come risultato, questo gruppo comprende diverse specie giganti visibili anche a occhio nudo.
Questi grandi solfo-batteri utilizzano nitrato ma, contrariamente ai batteri denitrificanti, sembra che riducano il nitrato ad ammoniaca e non a N2.
Quando la zona anaerobica coinvolge anche una porzione di colonna d'acqua dove penetra la luce, si possono sviluppare batteri fototrofi che utilizzano composti ridotti dello zolfo non a scopo energetico, ma come sorgente di elettroni per la fissazione della CO2 nel processo della fotosintesi anossigenica.
Questi microrganismi sono raggruppati come solfobatteri purpurei (ad esempio Chromatium, Thiocapsa, Thiopedia spp.) o verdi (ad esempio Chlorobium, Pelodictyon, Prosthecochlarius)
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
I batteri sono responsabili della degradazione e del riciclo di elementi essenziali come carbonio, azoto e fosforo, possono inoltre influenzare la disponibilità di metalli pesanti e svolgere altri importanti servizi ecosistemici.
Lo zolfo e il decimo elemento per abbondanza nella crosta terrestre ed e il sesto per abbondanza negli oceani con una concentrazione di 928 ppm.
È anche uno dei costituenti essenziali per i processi biosintetici di tutti gli organismi viventi.
Nell'acqua di mare si trova principalmente nella forma di ione solfato (SO4 2-), il piu accessibile per gli organismi viventi, ma si può trovare anche come solfuro di idrogeno (H2S), zolfo elementare (S0 ) e molecole organiche solforate.
Lo zolfo e anche utilizzato da diversi gruppi batterici, soprattutto nelle sue forme inorganiche, nei processi di produzione di energia metabolica.
Nelle cellule viventi lo zolfo è parte della struttura di molte molecole come amminoacidi (esempio metionina, cisteina), alcune vitamine, coenzimi e ormoni. Lo zolfo è anche utilizzato da diversi gruppi batterici, soprattutto nelle sue forme inorganiche, nei processi di produzione di energia metabolica.
Il ciclo biogeochimico dello zolfo comprende varie specie, organiche e inorganiche, che subiscono trasformazioni ad opera di agenti chimici o biologici, e che fluiscono tra i diversi comparti naturali.
Lo zolfo elementare viene ossidato aerobicamente da batteri zolfo ossidanti producendo ancora solfato.
Il solfato viene assimilato da una serie di microrganismi e organismi vegetali dando di nuovo via al ciclo.
Il riciclo dello S nella biosfera e molto rapido e i microrganismi marini hanno un ruolo fondamentale.
Come risultato di queste attività microbiche, il ciclo dello S ha connessioni multiple con i cicli degli altri elementi, in particolare C, N, P e Fe.
lo zolfo nella zona fotica viene assimilato dal fitoplancton e incorporato, in forma ossidata, in polisaccaridi solforati, ma soprattutto in aminoacidi quali metionina e cisteina.
La metionina e convertita dal fitoplancton in dimetilsolfoniopropionato (CH3)2S +CH2CH2COO- (DMSP) un composto con diverse funzioni.
Il suo effetto principale e osmoprotettivo in molte alghe, batteri e alcune piante acquatiche, in cui regola gli scambi osmotici tra l'ambiente esterno ed l'interno della cellula.
Ma ha anche altre funzioni: citoprotettivo, chemioprotettivo, ha un’attività antiossidante in alcune alghe marine e può limitare la predazione da parte dello zooplancton.
Poiché ogni molecola di DMSP contiene 5 atomi di C, la sintesi di questo composto e importante anche per il ciclo del carbonio.
Il 3-10% del carbonio fissato nella produzione primaria va a formare questa molecola, e quindi la sua degradazione fornisce circa il 3-10% della domanda di carbonio dei batteri eterotrofi nella zona oceanica superficiale.
Il DMSP viene successivamente rilasciato dal fitoplancton nell'ambiente esterno, in parte con la cosidetta essudazione, ma soprattutto a seguito di lisi cellulare, predazione, morte, e diventa così un elemento appetibile per molti organismi presenti in loco, tra cui batteri eterotrofi che lo utilizzano come fonte di carbonio, di energia, ma anche di zolfo, già presente in forma organica utilizzabile quindi per la biosintesi degli aminoacidi.
Il DMSP può subire due vie degradative diverse: 1. demetilazione con formazione di MMPA (3metil-mercaptiopropionato) che poi porta alla formazione di metanotiolo, il quale viene in seguito inserito nella via di sintesi degli aminoacidi;
2. rottura del DMSP con formazione di DMS, e la parte preponderante, circa il 90%, viene degradata da microrganismi anaerobi e aerobi.
Generalmente solo circa il 10% del solfuro prodotto dai solfato riduttori viene precipitato da ioni metallici.
Il resto è potenzialmente disponibile per l'ossidazione a S0 da parte di batteri chemiolitotrofi in grado di ossidare solfuro, zolfo elementare o tiosolfato (S2O3 2-) formando solfato come prodotto finale, stimolando nuovamente l'attività dei batteri solfato-riduttori.
Si tratta di microrganismi microerofili in quanto crescono preferibilmente in presenza di basse concentrazioni di ossigeno.
In questo processo di ossidazione molto importanti risultano essere i batteri filamentosi Beggiatoa e Thiothrix, Thiomargarita.
Si tratta di tre generi, strettamente correlati, che si sono adattati a ossidare il solfuro anche in assenza di O2 utilizzando il nitrato come accettore di elettroni.
Per riuscire a competere con altri solfuro-ossidanti, essi immagazzinano il nitrato delle acque profonde in un vacuolo e lo trasportano nel sedimento dove e prodotto il solfuro.
Per incamerare piu nitrato possibile, essi devono ingrandire i loro vacuoli e, come risultato, questo gruppo comprende diverse specie giganti visibili anche a occhio nudo.
Questi grandi solfo-batteri utilizzano nitrato ma, contrariamente ai batteri denitrificanti, sembra che riducano il nitrato ad ammoniaca e non a N2.
Quando la zona anaerobica coinvolge anche una porzione di colonna d'acqua dove penetra la luce, si possono sviluppare batteri fototrofi che utilizzano composti ridotti dello zolfo non a scopo energetico, ma come sorgente di elettroni per la fissazione della CO2 nel processo della fotosintesi anossigenica.
Questi microrganismi sono raggruppati come solfobatteri purpurei (ad esempio Chromatium, Thiocapsa, Thiopedia spp.) o verdi (ad esempio Chlorobium, Pelodictyon, Prosthecochlarius)
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
-
Andrea Frigerio
- Chrysiptera
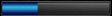
- Messaggi: 22
- Iscritto il: 18/06/2023, 20:43
Re: Zolfo in mare e in acquario Marino - ciclo dello zolfo
Stringo ancora un po’ così:
Il mio interesse è nato dal concetto di “sindrome della vasca vecchia” che ipotizzo essere correlato ad una sorta di “intasamento” delle rocce vive che possono così ospitare ambienti batteri anaerobi, mandando al collasso la vasca con alghe indesiderate. Addentrandomi nei dettagli del ruolo dello zolfo ho però notato che fa parte dell’equilibrio biochimico generale, ci vorrebbe una “teoria del tutto”, ma non so più da dove partire.
I principali cationi:
Na+
Mg2+
Ca2
K2+
Sr+
I principali anioni
Cl-
So42-
HCo3- e Co3
Br-
F-
H2BO3
Sodio e cloro danno la salinità, i cationi li misuriamo, il KH anche, lo zolfo?
I temi che attirano la mia attenzione:
Lo zolfo e anche utilizzato da diversi gruppi batterici, soprattutto nelle sue forme inorganiche, nei processi di produzione di energia metabolica.
Lo zolfo elementare viene ossidato aerobicamente da batteri zolfo ossidanti producendo ancora solfato.
Il solfato viene assimilato da una serie di microrganismi e organismi vegetali dando di nuovo via al ciclo.
Come risultato di queste attività microbiche, il ciclo dello S ha connessioni multiple con i cicli degli altri elementi, in particolare C, N, P e Fe.
lo zolfo nella zona fotica viene assimilato dal fitoplancton e incorporato, in forma ossidata, in polisaccaridi solforati, ma soprattutto in aminoacidi quali metionina e cisteina.
Quando la zona anaerobica coinvolge anche una porzione di colonna d'acqua dove penetra la luce, si possono sviluppare batteri fototrofi che utilizzano composti ridotti dello zolfo non a scopo energetico, ma come sorgente di elettroni per la fissazione della CO2 nel processo della fotosintesi anossigenica.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Il mio interesse è nato dal concetto di “sindrome della vasca vecchia” che ipotizzo essere correlato ad una sorta di “intasamento” delle rocce vive che possono così ospitare ambienti batteri anaerobi, mandando al collasso la vasca con alghe indesiderate. Addentrandomi nei dettagli del ruolo dello zolfo ho però notato che fa parte dell’equilibrio biochimico generale, ci vorrebbe una “teoria del tutto”, ma non so più da dove partire.
I principali cationi:
Na+
Mg2+
Ca2
K2+
Sr+
I principali anioni
Cl-
So42-
HCo3- e Co3
Br-
F-
H2BO3
Sodio e cloro danno la salinità, i cationi li misuriamo, il KH anche, lo zolfo?
I temi che attirano la mia attenzione:
Lo zolfo e anche utilizzato da diversi gruppi batterici, soprattutto nelle sue forme inorganiche, nei processi di produzione di energia metabolica.
Lo zolfo elementare viene ossidato aerobicamente da batteri zolfo ossidanti producendo ancora solfato.
Il solfato viene assimilato da una serie di microrganismi e organismi vegetali dando di nuovo via al ciclo.
Come risultato di queste attività microbiche, il ciclo dello S ha connessioni multiple con i cicli degli altri elementi, in particolare C, N, P e Fe.
lo zolfo nella zona fotica viene assimilato dal fitoplancton e incorporato, in forma ossidata, in polisaccaridi solforati, ma soprattutto in aminoacidi quali metionina e cisteina.
Quando la zona anaerobica coinvolge anche una porzione di colonna d'acqua dove penetra la luce, si possono sviluppare batteri fototrofi che utilizzano composti ridotti dello zolfo non a scopo energetico, ma come sorgente di elettroni per la fissazione della CO2 nel processo della fotosintesi anossigenica.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Re: Zolfo in mare e in acquario Marino - ciclo dello zolfo
Per me lo zolfo lo trovi solo sotto la sabbia. In zone anossiche, che in acquario non ci sono praticamente, in quanto si formano zone preferibilmente anaerobiche non essendoci adeguata distanza per condizioni in mancanza di ossigeno.
 DaniReef: il Portale di Acquariofilia più aggiornato che ci sia
DaniReef: il Portale di Acquariofilia più aggiornato che ci siaSe dovete fare una domanda cercate un articolo sul portale, al 99% c'è già la risposta
Acquario Nyos Opus 250 PRO - Schiumatoio Nyos Quantum 120 - Luce Orphek Natura - Risalita Octo VarioS 2 - Movimento 2x Octo Pulse Wave Pump OP-2
Re: Zolfo in mare e in acquario Marino - ciclo dello zolfo
La sindrome da vasca vecchia, é un'idea di fine anni '90 dove non si sapeva come si postesse comportare un sistema chiuso di all'ora sul lungo periodo.Andrea Frigerio ha scritto: ↑26/06/2023, 21:55Stringo ancora un po’ così:
Il mio interesse è nato dal concetto di “sindrome della vasca vecchia” che ipotizzo essere correlato ad una sorta di “intasamento” delle rocce vive che possono così ospitare ambienti batteri anaerobi, mandando al collasso la vasca con alghe indesiderate.
Oggi sappiamo che non é mai esistita e la moderna tecnica e chimica ci evita problemi di quel genere.
Il vero problema è arrivare ad avere vasche vecchie... ormai una vasca marina dura al massimo 3-5 anni e ogni scusa è buona per "smontare e ripartire"
Una stima molto limitata che non comprende sicuramente i più importanti... ~70 elementi chimici in acqua di mare, = circa 70 ioni, se consideri i possibili accoppiamenti non ce la si cava più!Andrea Frigerio ha scritto: ↑26/06/2023, 21:55Addentrandomi nei dettagli del ruolo dello zolfo ho però notato che fa parte dell’equilibrio biochimico generale, ci vorrebbe una “teoria del tutto”, ma non so più da dove partire.
I principali cationi:
Na+
Mg2+
Ca2
K2+
Sr+
I principali anioni
Cl-
So42-
HCo3- e Co3
Br-
F-
H2BO3
Sodio e cloro danno la salinità, i cationi li misuriamo, il KH anche, lo zolfo?
tutto si basa su ATP e ADP la fonte da cui prendere l'energia per il salto di stato, può essere differente a seconda dell'organismo considerato...Andrea Frigerio ha scritto: ↑26/06/2023, 21:55
I temi che attirano la mia attenzione:
Lo zolfo e anche utilizzato da diversi gruppi batterici, soprattutto nelle sue forme inorganiche, nei processi di produzione di energia metabolica.
Lo zolfo elementare viene ossidato aerobicamente da batteri zolfo ossidanti producendo ancora solfato.
Potrà anche essere vero, ma per quanto so di fitoplancton e terreni di allevamento, lo S non è sicuramente tra gli essenziali (se non perché ci si possa legare altro più significativo biologicamente)Andrea Frigerio ha scritto: ↑26/06/2023, 21:55
Il solfato viene assimilato da una serie di microrganismi e organismi vegetali dando di nuovo via al ciclo.
Come risultato di queste attività microbiche, il ciclo dello S ha connessioni multiple con i cicli degli altri elementi, in particolare C, N, P e Fe.
batteri che fissano la CO2 con fotosintesi ? = alghe...Andrea Frigerio ha scritto: ↑26/06/2023, 21:55
lo zolfo nella zona fotica viene assimilato dal fitoplancton e incorporato, in forma ossidata, in polisaccaridi solforati, ma soprattutto in aminoacidi quali metionina e cisteina. certo sono quelli che contengono S
Quando la zona anaerobica coinvolge anche una porzione di colonna d'acqua dove penetra la luce, si possono sviluppare batteri fototrofi che utilizzano composti ridotti dello zolfo non a scopo energetico, ma come sorgente di elettroni per la fissazione della CO2 nel processo della fotosintesi anossigenica.
Quali condizioni sono presenti in acquario di quelle citate sopra ?
Anaerobiosi della colonna d'acqua ? (forse all'interno di rocce vive selvatiche, in quelle artificiali, dubito)
Lo sviluppo di composti di zolfo fa puzzare l'acqua di uova marce (H2S) e se si va oltre si rischia anche di restarci secchi
dal 30-04-2025 a mia tutela non intervengo più nelle conversazioni-.
shark tale & mafia method
Davide.
shark tale & mafia method
Davide.
-
Andrea Frigerio
- Chrysiptera
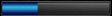
- Messaggi: 22
- Iscritto il: 18/06/2023, 20:43
Re: Zolfo in mare e in acquario Marino - ciclo dello zolfo
Ciao Danilo ciao Davide, grazie per le risposte.
Lo zolfo elementare si lega certamente a vari ioni, non mi aspetto che in vasca si arrivo a riduzioni di Fe o Mn, qualcuno perseverando avrebbe certamente avvertito l’odore fatiscente o ci avrebbe lasciato la pelle se fosse possibile arrivare a tanto. La prima reazione dello zolfo in un dsb è legata agli no3 in quanto primo a scambiare elettroni, sempre che ci siano i batteri, non si andrà oltre. La mia vasca o meglio le rocce hanno 11 anni, trasferita ormai un paio di anni fa in una un po’ più grande, in progetto di trasloco in una ancora più grande e credo definitiva. Si, sento tante situazioni in cui le cose girano male e si rifà tutto e basta.. ad ogni modo, mi sto concentrando sulla composizione dell’acqua di mare e sugli ioni ed è una missione… un po’ impossibile, ma cerco di limitarmi alle interazioni degli ioni con lo zolfo. Devo ancora capire se considerarlo oppure no come fonte di energia metabolica e se il fitoplancton lo assimila in forma ossidata. Vi giro un trend dello zolfo come elemento preso da ICP mensili

Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Lo zolfo elementare si lega certamente a vari ioni, non mi aspetto che in vasca si arrivo a riduzioni di Fe o Mn, qualcuno perseverando avrebbe certamente avvertito l’odore fatiscente o ci avrebbe lasciato la pelle se fosse possibile arrivare a tanto. La prima reazione dello zolfo in un dsb è legata agli no3 in quanto primo a scambiare elettroni, sempre che ci siano i batteri, non si andrà oltre. La mia vasca o meglio le rocce hanno 11 anni, trasferita ormai un paio di anni fa in una un po’ più grande, in progetto di trasloco in una ancora più grande e credo definitiva. Si, sento tante situazioni in cui le cose girano male e si rifà tutto e basta.. ad ogni modo, mi sto concentrando sulla composizione dell’acqua di mare e sugli ioni ed è una missione… un po’ impossibile, ma cerco di limitarmi alle interazioni degli ioni con lo zolfo. Devo ancora capire se considerarlo oppure no come fonte di energia metabolica e se il fitoplancton lo assimila in forma ossidata. Vi giro un trend dello zolfo come elemento preso da ICP mensili

Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti